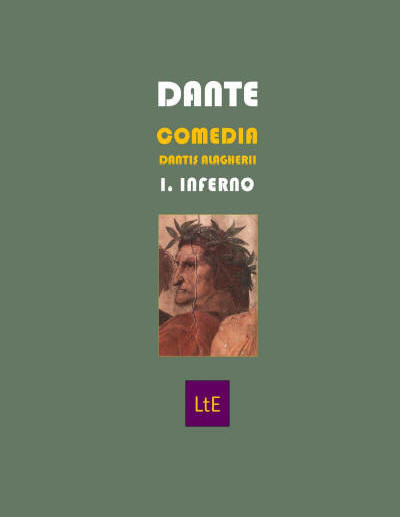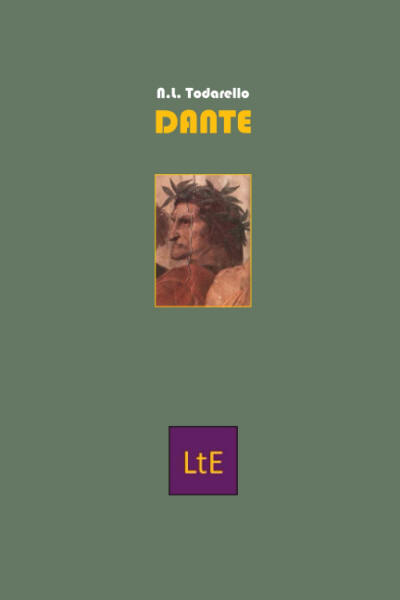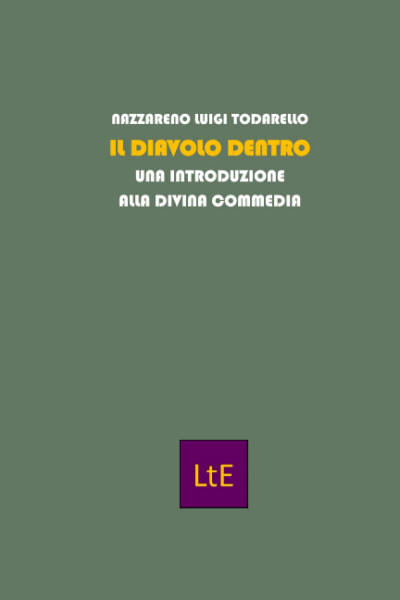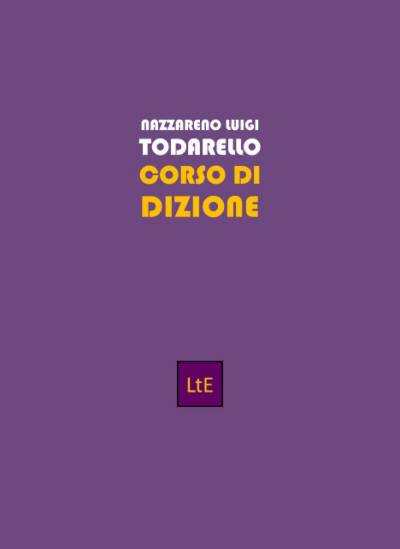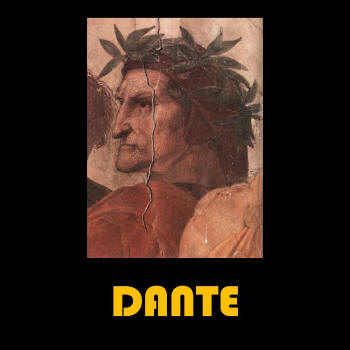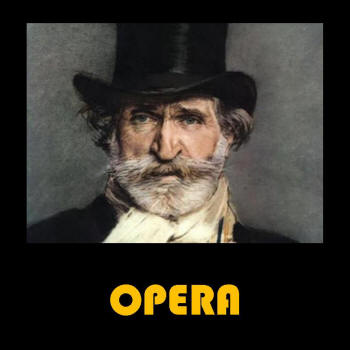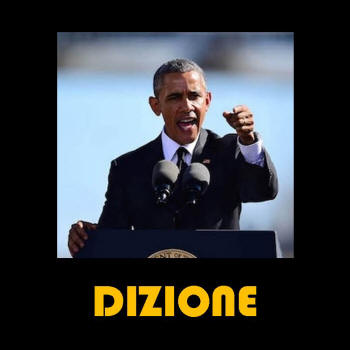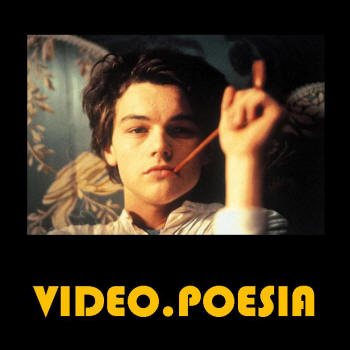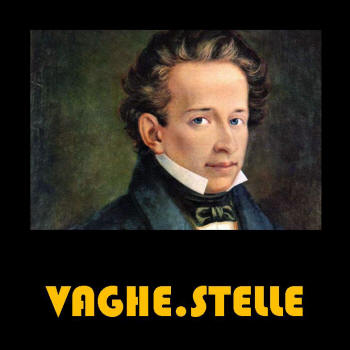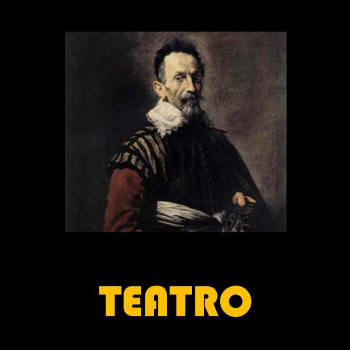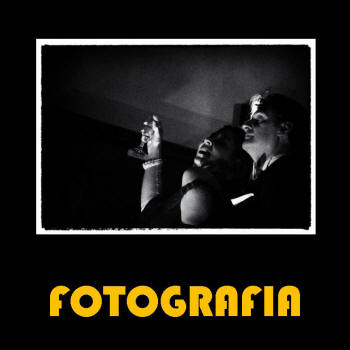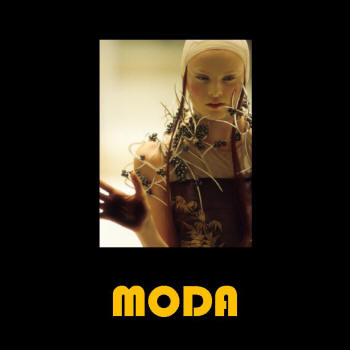|
LATORRE EDITORE OPERAMONDOlibri
ESPANSIONI |
|
DANTE ALIGHIERI
COMMEDIA INTRODUZIONE  IL GRANDE LIBRO DEI MORTI
“Nel
mezzo del cammin di nostra vita, così inizia, come tutti
sanno, il più grande poema scritto da un cristiano…”.
Così inizia il racconto della
Divina commedia di Vittorio Sermonti. Non c’è dubbio: il poema di
Dante è il massimo poema scritto da un cristiano… ma
forse non solo da un cristiano… il massimo poema
dell’Occidente, si potrebbe dire. Ma Omero? e Virgilio?
Ma, anche, gli altri cristiani?
La Chanson de
Roland e il
Furioso e la
Gerusalemme? Sono tanti i grandi poemi della
tradizione occidentale, prima e dopo la
Divina commedia. Vogliamo fare classifiche? Meglio di no, anche se…
Diciamo comunque: tra i quattro cinque massimi
capolavori poetici della nostra civiltà (“l’ultimo
miracolo della poesia mondiale”, ha scritto Eugenio
Montale). Capolavori immaginati e scritti in epoche
diverse, quindi tutti diversi uno dall’altro. Ma tutti
“poemi”. Cosa li lega uno all’altro? Che sono poemi,
naturalmente, cioè che sono scritti in versi e non in
prosa. Nella prosa le parole camminano, o marciano o
corrono, liberamente, nella poesia seguono un ritmo
costante: danzano. E perché farle danzare? Perché i
poemi non erano scritti per essere letti ma per essere
ascoltati. I versi aiutavano la memoria di chi cantava e
aiutavano la fantasia di chi ascoltava. Le parole
cantavano e danzavano e così creavano lì davanti e
d’intorno una incantatoria bolla di spazio vibrante,
fuori dal tempo e dallo spazio ordinari. Allo stesso
modo nel mezzo cerchio di pietra ad Atene i coreuti
cantando e danzando intrecciavano lo scongiuro capace di
obbligare a scendere gli spiriti e gli dei. La poesia,
da sempre, ha a che fare con i morti. Intorno al poeta
che canta appaiono gli spiriti dei morti. Anche oggi.
Anche Dylan Thomas, anche Montale: “Caro piccolo insetto
/ che chiamavano mosca non so perché, / stasera quasi al
buio / mentre leggevo il Deuteroisaia / sei ricomparsa
accanto a me, …”. Il poeta è un medium. Ulisse ed Enea
scendono negli inferi, perché “devono” parlare coi
morti. Dante, che era un uomo eccessivo, nel suo poema,
del quale fa protagonista se stesso, parla sempre e solo
coi morti. La
Divina commedia è un’enorme tomba. Dante scende
nella tomba e, aiutato da quel mago spiritista che è il
Virgilio medievale, risveglia i sepolti, perché “deve”
parlare con loro. E loro, volenti o nolenti, rispondono,
perché le parole danzanti sono fascinose e obbliganti.
Alla potenza medianica della poesia gli spiriti non
sanno/non possono opporsi. E qui i poeti sono due! Così
i morti parlano di sé, della vita che hanno lasciato,
del peccato che hanno o non hanno redento, degli amori e
degli odi. Con le parole dei morti che, tramite Dante,
incontriamo, entriamo in un mondo lontano, un mondo che
è stato reale e che la poesia del grande fiorentino rifà
reale ogni volta. Sono circa settecento i morti che
Dante incontra direttamente o indirettamente, o ai quali
accenna in qualche modo, o evocati dagli evocati. Morti
che, fatti anime, “vivono” negli spazi reali
dell’universo geocentrico. Perché il viaggio di Dante è
nel cosmo (“e già la luna è sotto i nostri piedi[1]”),
un cosmo eterno pullulante di trapassati, come la città
di Firenze e tutte le città medievali, “città-cimitero”.
“La
città medievale sarà – in totale contrasto con la città
antica – una città di vivi e di morti. I cadaveri non
saranno più rigettati, in quanto impuri, all’esterno
dello spazio urbano, ma – secondo l’esempio e per
l’attrazione dei corpi dei martiri – verranno insediati
nel territorio
intra muros. Tombe isolate, sepolcri costruiti nelle
chiese o cimiteri urbani faranno della città una
necropoli al tempo stesso che una città di viventi, e
l’immagine urbana avrà un aspetto funerario che
contribuirà a trasformarla profondamente. L’inurbamento
dei morti è un elemento capitale nella rivoluzione
urbana – materiale e mentale – del Medioevo.” (Le Goff
1982A).
Tramite la voce di san Pietro, Dante chiama la città di
Roma “cimitero”:
“Se
io mi trascoloro,
non
ti maravigliar, ché, dicend' io
vedrai trascolorar tutti costoro.
Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio,
il
luogo mio, il luogo mio che vaca
ne la
presenza del Figliuol di Dio,
fatt'
ha del cimitero mio cloaca
del
sangue e de la puzza; onde 'l perverso
che
cadde di qua sù, là giù si placa.”
Par.
XXVII 19-27
Il
papa Bonifacio VIII, che usurpa il trono papale, ha
trasformato il cimitero di san Pietro in una cloaca di
corruzione, nella quale Lucifero, scacciato dai cieli,
trova il suo risarcimento.
La
Commedia è un
affresco grandioso, non dissimile dai grandi cicli
giotteschi, ma ancora più carnoso e vibrante. La grande
arte di Dante è fotografica: i suoi ritratti, come le
migliori istantanee, colgono l’attimo significante. Sono
sprazzi, accenni, che il lettore contemporaneo, al quale
Dante pensa costantemente, coglieva al volo. A noi, dopo
sette secoli, molte cose sfuggono. Ma la fatica di
andare a cercare chi erano è ripagata dalla riemersione
di un mondo, il mondo reale di Dante, nel quale agivano
persone conosciute e ignote, santi e re, banchieri e
artigiani, ladri, preti e sodomiti. Un mondo del quale
erano parte attiva (come modelli, come suggestioni)
anche le lontane figure del mito e gli ammirati Romani.
La
Commedia è un
itinerarium mentis in Deo. Gli ultimi versi ci descrivono la
raggiunta unità dell’uomo/viaggiatore con Dio:
A
l’alta fantasia qui mancò possa;
ma
già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì
come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle.
Par.
XXXIII 143-145
L’alta fantasia è la capacità di rappresentare il percepito, cioè di fornire immagini all’intelletto. L’esperienza del divino non è rappresentabile e, di conseguenza, non è riferibile, non la si può raccontare. All’alta fantasia, dice Dante, venne meno la possa, il potere di farlo. Ora il desiderio e la volontà (il velle) sono mosse con moto uniforme ed eterno, sempre uguale a se stesso, dallo stesso amore che muove le stelle e tutto l’universo. Guardando all’opera intera dal punto di vista della sua conclusione, ne percepiamo l’essenza di libro mistico, di “manuale” cum figuris per la salvazione. Dante è stato capace di offrirci in un solo colpo d’occhio il tutto dell’esperienza umana. Non poteva farlo se non osservandola dal di fuori, mettendosi cioè fuori del tempo terreno e innalzandosi nello spazio siderale.
[1]
Inf.
XXIX 10.
OPERAMONDOlibri OPERAMONDOlibri LATORRE EDITORE
 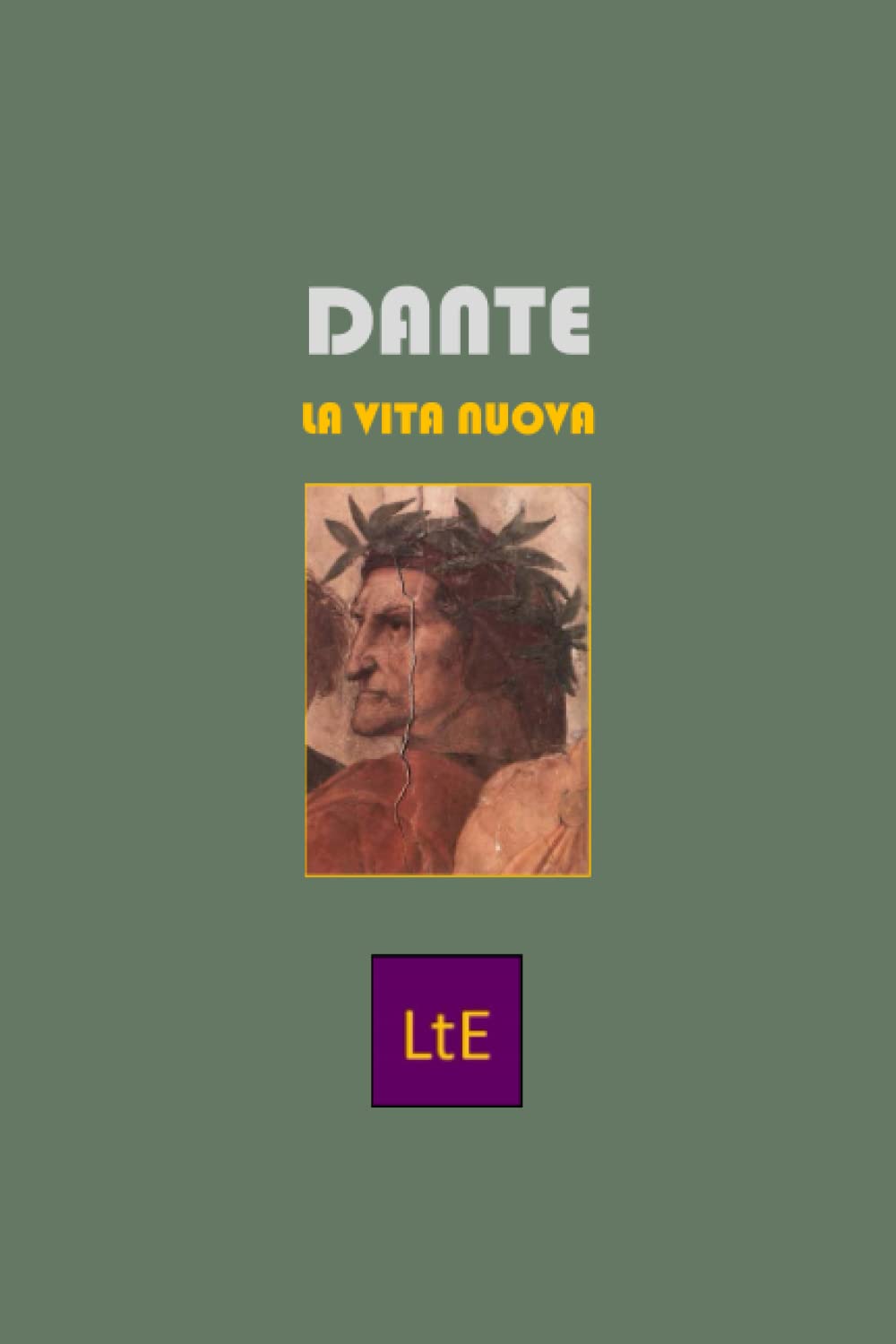 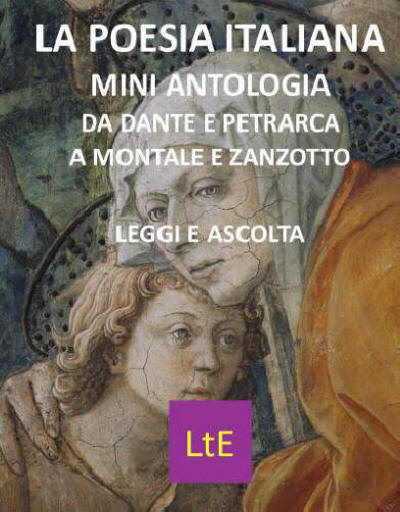
OPERAMONDOlibri LATORRE EDITORE |
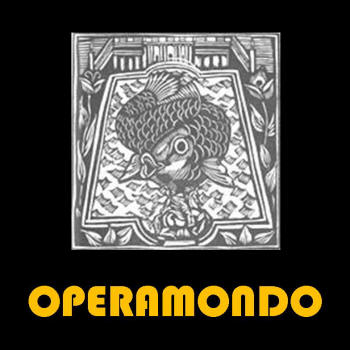
Copyright 2022
LATORRE EDITORE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA 23
15067 NOVI LIGURE AL ITALY
+39 339 22 50 407