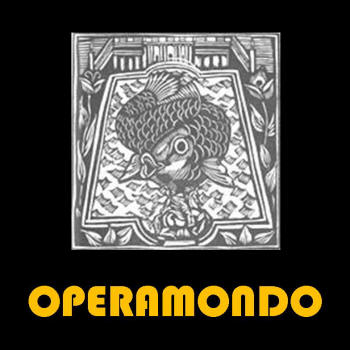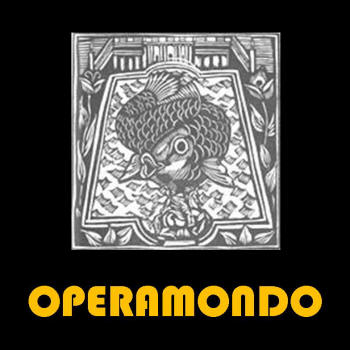Il fascino immenso che la
Commedia
emana deriva dalle molteplici suggestioni che il lettore
può ricavarne. Ne è prova la mole stupefacente di
interpretazioni che ne sono state date nei secoli.
L’opera è lì, ferma nel tempo. Ogni epoca ne privilegia
un aspetto o l’altro, ogni epoca con le sue ragioni. È
la caratteristica dei grandi capolavori. Virginia Woolf
scrisse di Amleto:
“L’ho letto a vent’anni e mi parlava di me; poi a
quaranta e parlava di nuovo di me; lo sto leggendo a
sessant’anni e sembra che Shakespeare abbia scritto
quelle parole per me”. Oggi noi, lettori di Dante del
terzo millennio, redattori di post autocelebrativi e del
tutto intenti al privato nostro e altrui, tendiamo a
privilegiare la dimensione umana della
Commedia: la
vicenda personale di Dante.
Il viaggio raccontato da Dante Alighieri nella sua
Commedia
inizia in una selva. Sono state spese molte parole per
dare significato a questa selva. Non parole inutili. La
Commedia
merita ogni attenzione. Ma è certa una cosa: Dante ci
dice che, a metà della sua vita, della sua vita non
sapeva che farsene. Capita a tutti, prima o dopo. A
trentacinque anni sembra un po’ tardi, considerando
anche che allora si viveva meno a lungo. Ma i primi
trentacinque anni di Dante sono stati molto pieni.
Avvenimenti personali e politici, avventure amorose,
spirituali e carnali, disavventure di ogni tipo,
esperienza di uomini. Dante si trova ora in esilio, non
può ragionevolmente pensare di tornare a Firenze, dove è
rimasta, in povertà, la sua famiglia. Non possiede più
nulla. Ogni bene gli è stato confiscato. Ha servito il
suo paese da amministratore onesto. Ha addirittura
condannato all’esilio Guido Cavalcanti, suo “primo
amico”, ma nobile litigioso, disubbidiente e riottoso.
Per esigenze di ordine pubblico, Dante, in qualità di
priore, lo ha mandato in esilio, con altri quattordici
irrequieti Bianchi e Neri. A Sarzana, allora paludosa e
malarica, da dove tornerà dopo un paio di mesi ammalato
e vicino alla morte.
La selva quindi, il non sapere che fare della propria
vita. Nel senso concretissimo di non sapere come
mantenersi in vita. E in tutti gli altri sensi. Aver
buttato gli anni migliori, ora che ogni attività, ogni
desiderio, ogni studio e ogni aspettativa sono ridotti a
un pugno di mosche. Dante si trova senza nulla, con la
sensazione di non aver combinato niente di decisivo, di
duraturo. La sua cultura, anche lei, la poesia, non
sembrano contare molto ormai. Possiamo dirlo: come tanti
giovani prima e dopo di lui, Dante ha il diavolo in
corpo. Possiamo chiamarlo in tanti modi quel diavolo che
a un certo punto prende possesso dell’anima giovane.
Possiamo chiamarlo depressione, crisi giovanile, droga,
alcool, sesso senza senso, assenza di significato,
fastidio della vita, fastidio degli adulti, degli altri,
delusione, cuore infranto, sogni infranti, mancanza di
prospettive, voglia di buttare via tutto, senso totale
di inutilità, voglia di morire.
Per qualche attimo, nel primo canto della
Commedia,
Dante si illude di poter risolvere. Vede la luce e la
insegue. È in salita la strada, ma lui è giovane, ed è
primavera. Ecco però che il diavolo che gli sta dentro
si fa vivo: tre animali feroci, tre visioni, venute
fuori dal tetro nulla che sta nell’anima, gli
impediscono l’andare. Lo ricacciano nella foresta
spaventosa. Sembra non esserci ormai altra via che la
morte. Le parole che usa Dante sono proprio queste:
paura, morte. Non paura di morire. O meglio non solo
paura di morire. Anche desiderio di morire per porre
termine alla paura insopportabile.
Dante ha il diavolo in corpo. E il diavolo sembra essere
sul punto di vincere. Non lo lascia avanzare, gli
impedisce ogni salita, la luce si allontana. Non c’è
possibilità di scorciatoie. Deve affrontarlo quel
diavolo maledetto che gli sta succhiando la vita, quel “mangiamorte”
che sta impadronendosi totalmente di lui. Deve andare
giù e guardarlo in faccia. “A te convien tenere altro
vïaggio” gli dice il fantasma di Virgilio, apparso
all’improvviso nello stesso modo nel quale sono apparse
le tre bestie feroci. Generato dunque dall’anima malata
di Dante. E quel “convien” è un ordine non un invito.
“Tu devi scendere nell’abisso. Solo così potrai
riprendere possesso di te stesso e cominciare
faticosamente a risalire”. Il diavolo in corpo è il
punto di partenza del viaggio dentro se stesso. E verso
se stesso. Alla fine ci sarà la luce. Non ci sono
garanzie di successo. Tutto dipende dalla forza, dal
coraggio, dalla verità. Ma non c’è altra strada.
Scorciatoie non ne esistono. Bisogna aprire gli occhi e
scendere. Così come farà, qualche secolo dopo un altro
giovane in lotta con il suo diavolo, Franz Kafka, che
scriverà a un certo punto della sua guerra: “Solo nel
profondo dell’inferno è possibile sentire il canto degli
angeli”.
Dante vedrà la luce. Ora non sa se potrà farcela. Ma
alla fine la vedrà. E allora tutto gli sarà chiaro.
Vedrà, in quella luce, una figura umana, un viso. Un
viso di uomo, l’incarnazione che ha messo in contatto
umano e divino, facendoli diventare una cosa sola. Ma
per vederlo quel viso occorre vedere tutto il resto,
fino in fondo. Così Dante ci racconta l’avventura di
ogni uomo che non voglia rassegnarsi a vivere sottomesso
al suo diavolo.